L’App dedicata ai clienti con codice fiscale per gestire le utenze luce e gas in modo smart.
Realizzare edifici sicuri, accoglienti e a basso impatto ambientale che sfruttino forme di energia rinnovabile e tecnologie innovative: oggi si può, grazie alla bioedilizia, una tecnica di costruzione e progettazione degli immobili attenta all’ambiente e sempre più diffusa negli ultimi anni. A favore dell’ambiente, della salute e promotrice del risparmio energetico, l’architettura sostenibile rappresenta la migliore alternativa a quella tradizionale e che si sposa per chi vuole adottare un approccio sempre più green. Vediamo cos'è la bioarchitettura e quali sono i protocolli di sostenibilità energetico ambientali che un edificio sostenibile è tenuto a rispettare.
LPer capire quando possiamo parlare di architettura ecosostenibile è importante chiarire il significato di bioedilizia: l’espressione si riferisce a tecniche di costruzione ecologica che pongono al centro il rispetto dell’ambiente e della persona. L’approccio culturale, ancor più che disciplinare, nasce in Germania negli anni Settanta e si sviluppa attorno al concetto di sostenibilità.
Applicare criteri di sostenibilità in architettura vuol dire progettare edifici e spazi che rispettano l'ambiente e riducono l'impatto negativo sul pianeta dell’architettura green è quello di integrare l’edificio e il contesto che lo circonda tramite l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e interventi di riqualificazione energetica.
Realizzare un edificio sostenibile significa, per esempio, ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) nell’ambiente, limitare gli sprechi di energia e acqua, ottimizzare i consumi, rispettare la biodiversità e migliorare la qualità dell’aria.

Sostenibilità e architettura sono quindi gli elementi chiave della bioedilizia. L’architettura sostenibile si ispira ad alcuni principi cardine. Scopriamoli nel dettaglio.
Si può definire dunque sostenibile un edificio in cui sarà possibile favorire il ricircolo naturale dell’aria, riscaldare e raffreddare gli ambienti senza sprechi energetici e orientare gli spazi abitativi in modo da garantire la migliore esposizione possibile alla luce. Un palazzo costruito secondo le regole dell’ecosostenibilità sarà inoltre ben isolato dal freddo e dal caldo, e dotato di sistemi per contenere i consumi idrici.
La scelta dei materiali riveste un’importanza cruciale nella bioedilizia. La priorità viene data a quelli provenienti da fonti rinnovabili, che, oltre a ridurre gli sprechi, non rilasciano sostanze tossiche o nocive per la salute umana, sia durante la fase di costruzione che durante l'uso dell'edificio. Accanto ad essi se ne utilizzano di più tradizionali oppure ricavati dal riciclo di materie prime. I più diffusi sono legno, mattoni, paglia, legno-cemento, sughero, bambù, fibra di cellulosa, di legno mineralizzata, di juta o di canapa, argilla o calce espansa.
La bioarchitettura è la naturale evoluzione della bioedilizia. I principi della bioedilizia combinati con quelli del design, hanno dato vita alla cosiddetta architettura green. Come abbiamo avuto modo di osservare finora, gli edifici green portano benefici ai suoi abitanti e migliorano l’ambiente circostante. Riutilizzare spazio e materiali senza recare danno all’ambiente è diventato quindi uno degli aspetti che gli architetti tengono maggiormente in considerazione.
La bioarchitettura in Italiasi è diffusa negli anni ’90 del ventesimo secolo grazie alla spinta di Ugo Sasso, pioniere dell’architettura sostenibile nel nostro paese dove l’esempio più iconico è rappresentato dal Bosco verticale di Milano, un progetto di riforestazione metropolitana realizzato da Boeri Studio tra il 2009 e il 2014 per favorire e proteggere la biodiversità del territorio. Formato da due torri, ospita oltre 800 alberi e 94 specie di piante che contribuiscono a creare un microclima in grado di produrre ossigeno, assorbire CO2, filtrare le polveri sottili, depurare l’aria e attenuare l’inquinamento acustico. Con 500 metri quadrati di pannelli solari e sistemi di irrigazione che sfruttano un impianto centralizzato di filtrazione delle acque grigie (quelle provenienti ad esempio da lavandini, docce, lavatrici), l’intero complesso è in grado di recuperare e produrre energia.
Sempre nel capoluogo lombardo sorge poi la nuova Torre Gioia 22, un grattacielo di 120 metri e 30 piani realizzato grazie a un sistema di progettazione “Cradle to Cradle” (o C2C, termine coniato dagli architetti William McDonough e Michael Braungart nel loro libro Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things), vale a dire un modello di design sostenibile che promuove la produzione e il consumo di beni in un ciclo chiuso e continuo, dove i materiali vengono costantemente riutilizzati senza creare rifiuti. La Torre, che ha ottenuto la LEED Certification (Leadership in Energy and Environmental Design) riservata ai progetti edilizi che si contraddistinguono per efficienza energetica e impronta ecologica, è stata progettata dall’architetto Gregg Jones, ed è il primo edificio italiano costruito secondo gli standard NZEB (Nearly Zero-Energy Building) che caratterizzano gli edifici con un consumo energetico quasi pari a zero. La Torre Gioia 22 è stata costruita al posto dell’edificio ex INPS di Via Melchiorre Gioia e produce energia grazie a 6 mila metri quadrati di pannelli fotovoltaici che permettono una riduzione di tre quarti del fabbisogno energetico delle altre torri di Porta Nuova.
Tra gli edifici ecosostenibili in Italia rientra anche “La Balena” di Reggio Emilia, un edificio progettato da MCArchitects, che oggi ospita un asilo nido; lo stabile è composto da una successione di telai in legno che ripropongono la forma della pancia della balena di “Pinocchio”. Il legno permette un ottimo livello di coibentazione, mentre un sistema di riciclo dell’acqua piovana e un impianto fotovoltaico in copertura garantiscono alti standard di sostenibilità.
Esempi di architettura sostenibile e bioedilizia sono presenti anche nel resto del mondo: ad Amsterdam si può ammirare The Edge, l’edificio più ecologico al mondo, che dal 2015 ospita gli uffici più importanti della città olandese. I pannelli solari sulla facciata rivolta a sud gli consentono di autoprodurre elettricità, mentre l’acqua piovana raccolta viene usata per all’interno dell’edificio e per irrigare le aree verdi. In Cina spicca l’esempio della Shanghai Tower, un edificio di 127 piani in grado di ospitare oltre 16 mila persone. La torre è dotata di turbine eoliche incorporate nella facciata per alimentare l’illuminazione esterna e di un impianto geotermico e di riciclo dell’acqua; l’involucro esterno realizzato con doppio strato garantisce l’isolamento totale dell’edificio. A Melbourne in Australia il primato di architettura ecosostenibile spetta a edifici come il Forte Building, una torre di 10 piani completamente green, o il Pixel Building, inaugurato nel 2010, un palazzo per uffici a zero emissioni e in grado di generare in modo autonomo energia e acqua.
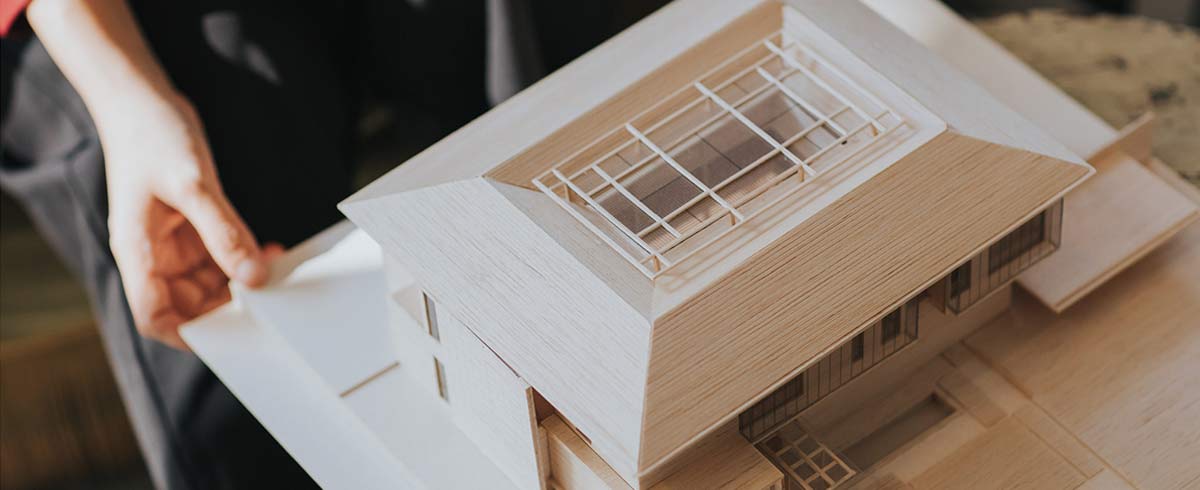
Per misurare la sostenibilità di un edificio (in costruzione o già esistente) sono stati creati dei protocolli, ovvero sistemi di certificazione su base volontaria che fungono da linee guida.
Tali sistemi non si limitano a valutare solo l’efficienza energetica, ma tengono conto anche dell’impatto della costruzione sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. Il protocollo attualmente più utilizzato nel mondo è il già citato LEED. Sviluppato negli Stati Uniti, valuta la sostenibilità di un edificio in base a sei criteri:
Alla fine della valutazione vengono assegnati dei crediti e la loro somma determina il livello di certificazione assegnato: Base, Argento, Oro e Platino.
Dagli Stati Uniti arriva anche la certificazione WELL Building standard o semplicemente WELL, che definisce la sostenibilità degli edifici attraverso criteri basati esclusivamente sulla salute e il benessere degli occupanti.
In Europa i protocolli più comuni sono:
il protocollo HQE (Haute Qualitè Environnementale), un sistema di certificazione sviluppato in Francia nel 1995 che valuta la l’intero processo edilizio sulla base di 14 fattori suddivisi tra le aree tematiche di bioedilizia (progettazione dell’edificio nel contesto ambientale, scelta di materiali e tecnologie, cantiere a basso impatto), ecogestione (come vengono gestite energia, acqua e rifiuti), comfort (igrotermico, quindi dal punto di vista dell’umidità, acustico, visivo e olfattivo) e salute, ovvero le condizioni igieniche, dell’acqua e dell’aria.
In Italia vige invece il protocollo ITACA, elaborato nel 2002, l’edificio viene valutato secondo una scala da -1 a +5, e considera cinque aree di valutazione:
Il protocollo ITACA valuta il livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici, verificandone inoltre le prestazioni energetiche e l’impatto sull’ambiente e sulla salute delle persone. Il protocollo ITACA adotta indicatori e metodi di verifica conformi alle norme tecniche e alle leggi nazionali di riferimento, per garantire l’oggettività delle valutazioni.
Insieme al protocollo ITACA, viene spesso adottato il protocollo CasaClima Nature che, oltre a valutare l’impatto ambientale di una costruzione in fase di realizzazione, prende in considerazione anche la salute e il comfort dei suoi abitanti. Le aree di valutazione riguardano:
La valutazione finale assegna diverse classi energetiche:
08 ottobre 2024 |